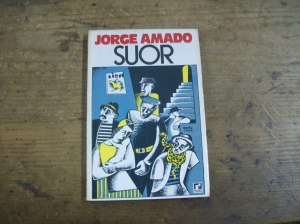Ingannare l’attesa. Ingannare. Si inganna qualcuno su cui ci si vuole rivalere, qualcuno che ci ha fatto un torto, che non ci piace. Non ci piace l’attesa. Il tempo dell’attesa è tempo perso, tempo sprecato. Tempo che dobbiamo ingannare. Fregare. Fare qualcos’altro invece di attendere. Perché attendere e basta non si può? Perché non si riesce a entrare nell’ordine di idee secondo cui il tempo in cui si è aspetta è tempo in cui si aspetta, semplicemente, senza inganni o trucchi. Ciò che si fa nel tempo dell’attesa è attendere, attendere è l’attività che svolgiamo in quel momento. Perché quest’horror vacui, questa incapacità di incrociare le braccia e fermarsi per un attimo e rispondere alla domanda “che cosa fai?” nel più semplice dei modi: “aspetto”?
Intervista a Wu Ming 4
In una Bologna stretta nella morsa dell’afa estiva, Wu Ming 4, al secolo Federico Guglielmi, ci fa accomodare sul divano della sua abitazione per parlare, tra le altre cose, del libro di prossima uscita a firma del collettivo bolognese, incentrato sugli eventi della rivoluzione francese. “L’armata dei sonnambuli”, la cui uscita è prevista per gennaio 2014, è il secondo romanzo ambientato nel ‘700 dopo “Manituana”, insieme a “Q” uno tra i principali successi editoriali del gruppo, attivo anche su internet con il blog Giap.
La prima domanda che volevamo farti riguarda “L’armata dei sonnambuli”, la vostra ultima fatica letteraria. Avete dichiarato di voler, con questo libro, demolire il “monumento” Rivoluzione Francese. Vi riferite a quello edificato dalla storiografia revisionista o a quello più banalmente della storiografia classica?
 Con Furet e compagnia è senz’altro ora di farla finita, hanno avuto spazio a sufficienza. Il nostro obiettivo non è però la storiografia. Noi scriviamo romanzi, non scriviamo per confrontarci con le tesi storiografiche. Ne teniamo conto, certo. Le varie scuole storiografiche, i filtri, si frappongono tra te e l’evento che hai deciso di narrare. Il nostro sforzo stavolta è stato quello di provare a raccontare con una certa leggerezza, dal momento che il problema storiografico rischiava di schiacciare completamente la storia, trattandosi di un momento così importante, fondativo, germinale… ma anche di un microcosmo, in un certo senso, perché nella Rivoluzione Francese c’è già, in nuce, tutto quello che si svilupperà nella modernità. Abbiamo avuto per certi versi un problema inverso rispetto agli altri momenti storici che abbiamo scelto per le nostre storie – penso a Q e Manituana – decisamente più oscuri. La Rivoluzione Francese invece è l’evento con la E maiuscola della storia contemporanea. La sfida è stata scegliere dei personaggi che la attraversassero e abbiamo deciso che il loro punto di vista sarebbe stato quello della strada. Perfino i personaggi che non appartengono alle classi sociali più basse vivono degli avvenimenti che li portano a contatto con una quotidianità spicciola. Le grandi discussioni politiche ci sono ma rimangono in qualche modo sullo sfondo. Assalti ai forni, spedizioni punitive contro gli accaparratori… sono questi gli eventi che impressionano il punto di vista della strada. La Convenzione, ad esempio, non è mai vista nella sua routine quotidiana ma nel momento in cui una delegazione di sanculotti entra per portare una petizione o lamentarsi di qualcosa. Noi siamo molto abituati a ragionare in termini di correnti politiche: ci sono i Girondini, ci sono i Giacobini, gli Arrabbiati… ma se tu sei una donna del popolo, vedova, con un figlio a carico, qual è il tuo ordine di priorità? Come vedi tutto questo? L’operazione è perciò narrativa, non storiografica. Si tratta di cogliere gli eventi in maniera immediata, senza starle a tematizzare più di tanto, come farebbe uno storiografo. Il nostro personaggio, che non ha elementi di storiografia, come lo vedrebbe questo evento?
Con Furet e compagnia è senz’altro ora di farla finita, hanno avuto spazio a sufficienza. Il nostro obiettivo non è però la storiografia. Noi scriviamo romanzi, non scriviamo per confrontarci con le tesi storiografiche. Ne teniamo conto, certo. Le varie scuole storiografiche, i filtri, si frappongono tra te e l’evento che hai deciso di narrare. Il nostro sforzo stavolta è stato quello di provare a raccontare con una certa leggerezza, dal momento che il problema storiografico rischiava di schiacciare completamente la storia, trattandosi di un momento così importante, fondativo, germinale… ma anche di un microcosmo, in un certo senso, perché nella Rivoluzione Francese c’è già, in nuce, tutto quello che si svilupperà nella modernità. Abbiamo avuto per certi versi un problema inverso rispetto agli altri momenti storici che abbiamo scelto per le nostre storie – penso a Q e Manituana – decisamente più oscuri. La Rivoluzione Francese invece è l’evento con la E maiuscola della storia contemporanea. La sfida è stata scegliere dei personaggi che la attraversassero e abbiamo deciso che il loro punto di vista sarebbe stato quello della strada. Perfino i personaggi che non appartengono alle classi sociali più basse vivono degli avvenimenti che li portano a contatto con una quotidianità spicciola. Le grandi discussioni politiche ci sono ma rimangono in qualche modo sullo sfondo. Assalti ai forni, spedizioni punitive contro gli accaparratori… sono questi gli eventi che impressionano il punto di vista della strada. La Convenzione, ad esempio, non è mai vista nella sua routine quotidiana ma nel momento in cui una delegazione di sanculotti entra per portare una petizione o lamentarsi di qualcosa. Noi siamo molto abituati a ragionare in termini di correnti politiche: ci sono i Girondini, ci sono i Giacobini, gli Arrabbiati… ma se tu sei una donna del popolo, vedova, con un figlio a carico, qual è il tuo ordine di priorità? Come vedi tutto questo? L’operazione è perciò narrativa, non storiografica. Si tratta di cogliere gli eventi in maniera immediata, senza starle a tematizzare più di tanto, come farebbe uno storiografo. Il nostro personaggio, che non ha elementi di storiografia, come lo vedrebbe questo evento?
Da questo punto di vista è stato senz’altro molto importante il lavoro sulle fonti.
La Francia è uno dei quei paesi, come gli Stati Uniti, o l’Inghilterra, che hanno mappato la loro storia in maniera molto dettagliata, rendendo pubbliche le fonti. In Italia siamo piuttosto indietro da questo punto di vista. Ricordo che quando scrivemmo Q uno di noi dovette andare a parlare con un cardinale per avere accesso alla Biblioteca Vaticana. Non ci siamo entrati poi, tra l’altro. Adesso esiste “Gallica” per la storia francese, che è un progetto veramente interessante, figlio di una cultura veramente enciclopedista. Si tratta di radunare le fonti principali della propria storia, digitalizzarle e renderle accessibili. La Rivoluzione Francese è una miniera di fonti perché, col boom della stampa – la libellistica, i fogli volanti, i quotidiani, i verbali dell’assemblea legislativa della Convenzione – c’è davvero una quantità di materiale enorme. Noi abbiamo scelto con questo romanzo di far parlare le fonti, come se fossero una voce in più. Abbiamo intervallato i vari blocchi di narrazione con degli stralci di fonti primarie, di vario tipo: possono essere articoli di giornale, parti di discorsi, cronache dell’epoca. È leggendo le cronache dei riot che si evince quali fossero i problemi percepiti dal basso. In certi casi la fonte ci ha suggerito semplicemente le scene da raccontare, in certi altri si tratta addirittura di pezzi di letteratura già scritti.
La prossima domanda si colloca un po’ a metà tra attività letteraria e attività politica: nella Rivoluzione Francese abbiamo, secondo la famosa tesi di Soboul, aggregazioni in parte interclassiste, certamente intersettoriali, attorno ad una rivendicazione. Mi pare un punto importante perché è qualcosa che oggi manca, l’unificazione di istanze differenti. La disomogeneità c’è anche oggi. E oggi però non si riesce mai ad afferrare quel mondo artigianale, preindustriale…
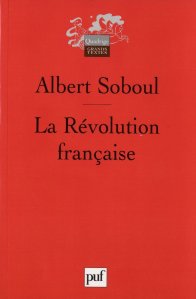 La nostra impressione, desunta più che da Soboul da alcuni della parte avversa, monarchici e reazionari, è che i Giacobini fossero una macchina da guerra già su tutto il territorio nazionale e funzionassero come un protopartito. Erano quasi tutti avvocati, quindi sapevano parlare, sapevano intervenire, avevano una buona retorica, erano gli uomini che in determinate circostanze potevano arringare una folla, redigere un documento. La parte avversa tendeva a esaltarli in senso negativo. Non ci sono dubbi sul fatto che abbiano ottenuto dei risultati. Si tende molto spesso a pensare ai Giacobini come ad un aspirante partito totalitario che instaura una sorta di cappa di controllo. Quello che le cronache ci restituiscono è in realtà una funzione, in qualche modo, da “pompieri” dei giacobini. Questo perlomeno nella fase che li vede affermarsi, in cui Montagnardi e Giacobini dovevano intrattenere un dialogo con la plebe parigina, certe stratificazioni, una certa coscienza di classe. La plebe parigina, i Sanculotti, erano effettivamente una specificità, che però condizionava fortemente un paese così accentrato. Di fronte alle istanze di questo protagonista politico i Giacobini sono dei pompieri. Come saldano i conti con l’ala più moderata della rivoluzione, i Girondini, così con l’ala più estrema, Leclerc, Hébert: il fatto che si ritrovino soli al comando è frutto di un tentativo di tenere la barra dritta. Anche nei confronti di chi avrebbe portato il terrore ben oltre. Noi di solito associamo a Robespierre e a Saint-Just la gran voglia di tagliar teste, in realtà la loro è una mediazione rispetto alla volontà popolare, che era di una resa dei conti pressoché definitiva. Quello che si chiedeva, in un certo senso, era di sterminare gli aristocratici, perché non potessero più tornare. Sono stati fatti degli errori interpretativi nelle vulgate che si sono affermate nel corso del tempo. Ma se vuoi raccontare una storia sono le prime cose di cui ti devi sbarazzare. A me Robespierre interessava come personaggio ma credo che compaia in una scena sola, forse due. È quello che rappresenta per gli altri personaggi ad essere ancora più interessante. Ma, riguardo alla domanda, il parallelo tra l’allora e l’oggi, si tratta di una questione abbastanza spinosa. È molto difficile dire perché allora sì e oggi no.
La nostra impressione, desunta più che da Soboul da alcuni della parte avversa, monarchici e reazionari, è che i Giacobini fossero una macchina da guerra già su tutto il territorio nazionale e funzionassero come un protopartito. Erano quasi tutti avvocati, quindi sapevano parlare, sapevano intervenire, avevano una buona retorica, erano gli uomini che in determinate circostanze potevano arringare una folla, redigere un documento. La parte avversa tendeva a esaltarli in senso negativo. Non ci sono dubbi sul fatto che abbiano ottenuto dei risultati. Si tende molto spesso a pensare ai Giacobini come ad un aspirante partito totalitario che instaura una sorta di cappa di controllo. Quello che le cronache ci restituiscono è in realtà una funzione, in qualche modo, da “pompieri” dei giacobini. Questo perlomeno nella fase che li vede affermarsi, in cui Montagnardi e Giacobini dovevano intrattenere un dialogo con la plebe parigina, certe stratificazioni, una certa coscienza di classe. La plebe parigina, i Sanculotti, erano effettivamente una specificità, che però condizionava fortemente un paese così accentrato. Di fronte alle istanze di questo protagonista politico i Giacobini sono dei pompieri. Come saldano i conti con l’ala più moderata della rivoluzione, i Girondini, così con l’ala più estrema, Leclerc, Hébert: il fatto che si ritrovino soli al comando è frutto di un tentativo di tenere la barra dritta. Anche nei confronti di chi avrebbe portato il terrore ben oltre. Noi di solito associamo a Robespierre e a Saint-Just la gran voglia di tagliar teste, in realtà la loro è una mediazione rispetto alla volontà popolare, che era di una resa dei conti pressoché definitiva. Quello che si chiedeva, in un certo senso, era di sterminare gli aristocratici, perché non potessero più tornare. Sono stati fatti degli errori interpretativi nelle vulgate che si sono affermate nel corso del tempo. Ma se vuoi raccontare una storia sono le prime cose di cui ti devi sbarazzare. A me Robespierre interessava come personaggio ma credo che compaia in una scena sola, forse due. È quello che rappresenta per gli altri personaggi ad essere ancora più interessante. Ma, riguardo alla domanda, il parallelo tra l’allora e l’oggi, si tratta di una questione abbastanza spinosa. È molto difficile dire perché allora sì e oggi no.
Il quadro era complesso ma senz’altro allora accadeva qualcosa.
Sarebbe facile dire che sono cose che succedono sull’altra sponda del Mediterraneo, perché lì la media dell’età è 25 anni mentre in Europa è 45… in realtà l’alchimia di fattori che porta ad un rivolgimento politico è più complicata.
A noi interessa sopratutto il fatto che letterariamente riusciate a rendere la complessità, le contraddizioni tra i subalterni.
Scrivere romanzi a tesi non interessa a nessuno. E a noi non interessa capire chi erano i buoni, nella Rivoluzione Francese. Non ha molto senso ragionare in questi termini quando hai a che fare con la storia, è più bello raccontare delle vicende avvincenti, avventurose, dei personaggi complessi. Ecco: rendere la complessità. Se c’è una lezione che uno può apprendere dal cinema, dal teatro, dalla drammaturgia è forse questa: cercare di portare in letteratura la complessità. Shakespearianamente, è il personale che si riverbera sul sociale, sul politico, e viceversa. È questo lo sforzo che dal punto di vista narrativo noi cerchiamo di fare. Anche se abbiamo scelto un punto di vista della strada non ci siamo sognati minimamente di abilitarlo come punto di vista buono e giusto. Ci sono scorrettezza, cattiveria e infamia anche – soprattutto – tra le classi più disagiate. Ci sono, certo, anche slancio e generosità. Noi scegliamo sempre la via più contraddittoria.
Venendo all’attualità, è molto noto il vostro articolo, frutto di una grande ricerca, sul M5S. Volevamo chiederti, relativamente alla tesi per la quale Grillo copre e gestisce lo spazio dei movimenti, un giudizio sul rapporto tra il M5S e il movimento dell’Onda. A me sembra che in quella fase i “gruppi dirigenti” del movimento cercassero di flirtare con questo tipo di narrazione e ci sia quindi stato un tentativo di cooptazione, che è poi in realtà stata una cooptazione contraria. In altre parole, voi dite che Grillo ha fagocitato i movimenti. Ma non è forse vero che anche i movimenti in Italia hanno la loro parte di colpa?
 Lo slogan “Non ci rappresenta nessuno”, se viene assunto come slogan problematico, è un conto; se risulta già di per sé soddisfacente, è un problema. Bisogna fare un passo indietro. Il fatto di non aver fatto chiarezza per tempo è certamente una responsabilità. Ma in questo caso la chiarezza non c’è stata neanche poi. Io credo che Grillo, lo spazio che ha occupato, sia nato in realtà con il movimento No Global. In quel passaggio, fine anni ’90-primi ’00, si è prodotta un’anomalia, la scollatura tra rappresentanza e movimenti. Prima c’erano micropartiti, Verdi, Rifondazione, Di Pietro, che provavano a stare dentro il movimento e a portare rappresentanza in parlamento. È stata un’esperienza fallimentare, questo lo possiamo dire col senno di poi. Io, a dire il vero, non ci credevo nemmeno durante…
Lo slogan “Non ci rappresenta nessuno”, se viene assunto come slogan problematico, è un conto; se risulta già di per sé soddisfacente, è un problema. Bisogna fare un passo indietro. Il fatto di non aver fatto chiarezza per tempo è certamente una responsabilità. Ma in questo caso la chiarezza non c’è stata neanche poi. Io credo che Grillo, lo spazio che ha occupato, sia nato in realtà con il movimento No Global. In quel passaggio, fine anni ’90-primi ’00, si è prodotta un’anomalia, la scollatura tra rappresentanza e movimenti. Prima c’erano micropartiti, Verdi, Rifondazione, Di Pietro, che provavano a stare dentro il movimento e a portare rappresentanza in parlamento. È stata un’esperienza fallimentare, questo lo possiamo dire col senno di poi. Io, a dire il vero, non ci credevo nemmeno durante…
Per me è stata una cantonata clamorosa.
 Per carità, siamo tutti sulla stessa barca. Tuttavia, l’esperimento è fallito. Così come è rimasta inespressa la problematica che quel movimento poneva. Devi risalire a quegli anni se vuoi ritrovare il punto d’origine. Il 21 luglio del 2001, all’indomani della morte di Carlo Giuliani, l’allora partito dei DS ritira i pullman che dovevano andare a Genova, toglie l’adesione alla manifestazione. D’Alema fa un appello dicendo “Non andate!”. Per fortuna, disobbediscono in tanti. Moltissime persone si trovano a Genova senza il più grande partito del centrosinistra. Per la prima volta chi proveniva da un percorso di sinistra abbandona la gente al macello. Si tratta di qualcosa di diverso da quello che è successo a Bologna nel ’77, per esempio. “Mando io l’esercito, vi seghiamo noi!”, quella è un’altra cosa, è un’assunzione di responsabilità. Chiamarsene fuori segna un passaggio significativo. Secondo me lì finisce una storia, quella del principale partito italiano del ‘900. Il resto è solo squallore e tristezza. E sconfitte. Perché se perdi quel legame, se non hai più la responsabilità del popolo che va in piazza, che è una cosa giusta, il passaggio è un passaggio politico.
Per carità, siamo tutti sulla stessa barca. Tuttavia, l’esperimento è fallito. Così come è rimasta inespressa la problematica che quel movimento poneva. Devi risalire a quegli anni se vuoi ritrovare il punto d’origine. Il 21 luglio del 2001, all’indomani della morte di Carlo Giuliani, l’allora partito dei DS ritira i pullman che dovevano andare a Genova, toglie l’adesione alla manifestazione. D’Alema fa un appello dicendo “Non andate!”. Per fortuna, disobbediscono in tanti. Moltissime persone si trovano a Genova senza il più grande partito del centrosinistra. Per la prima volta chi proveniva da un percorso di sinistra abbandona la gente al macello. Si tratta di qualcosa di diverso da quello che è successo a Bologna nel ’77, per esempio. “Mando io l’esercito, vi seghiamo noi!”, quella è un’altra cosa, è un’assunzione di responsabilità. Chiamarsene fuori segna un passaggio significativo. Secondo me lì finisce una storia, quella del principale partito italiano del ‘900. Il resto è solo squallore e tristezza. E sconfitte. Perché se perdi quel legame, se non hai più la responsabilità del popolo che va in piazza, che è una cosa giusta, il passaggio è un passaggio politico.
Anche a Roma, negli anni delle grandi manifestazioni per la pace, gli allora DS erano fortemente criticati perché loro quella guerra che il popolo era sceso in piazza per condannare l’avevano votata.
L’immagine dell’ambiguità era cominciata anche da prima, però è vero che ci sono dei momenti che sanciscono delle cesure. Quelli sono gli anni in cui, per venire a Grillo, Grillo fa degli spettacoli in cui strizza l’occhio al movimento No Global. Il suo discorso è un discorso in cui la politica non conta più niente: quelli che fanno il G8 sono le teste di legno delle multinazionali. I discorsi che faceva erano discorsi che avremmo sottoscritto tranquillamente. Io avevo i suoi DVD, poi li ho cacciati nella spazzatura dopo le affermazioni sui rom. Cosa succede poi? L’incontro con Casaleggio, l’ingresso in politica…
Il movimento era allora in una fase di riflusso conclamato.
Ma è naturale. Non aveva trovato uno sbocco nella rappresentanza, c’erano state grandi manifestazioni ma la guerra era comunque andata avanti. Dopo ci sono stati l’Onda e i riot studenteschi 2010-2011, però neanche quelli sono stati seminali. L’Onda sì, è stata abbastanza seminale. A Bologna c’era il Bartleby, che era nato dal 2008. Quello che mancava, e manca ancora adesso, è un quadro che unifichi. Bandiere NO TAV, ad esempio, tu ne trovi dovunque però la Val Susa è una lotta che dura da vent’anni, a portarla avanti sono le popolazioni che abitano in quel territorio, e la vinceranno. È il corrispettivo del Chiapas, per fortuna più vicino. Quello che per noi era il Chiapas – toccava prendere un aereo e andare in Messico – per molti oggi è la Val Susa. Tutto ciò ha prodotto uno scollamento. Ma non è per l’incapacità di gestirlo che Grillo è scoppiato. Grillo è scoppiato perché doveva scoppiare. Perché è un pallone gonfiato, un hype, una bolla – lui stesso. Quello che è mancato è stato qualcuno che dicesse “Queste istanze sono giuste, dobbiamo lottare contro questo tipo di sistema…” Prendi la casta, questo termine orribile inventato da Stella. Le caste sono caste per nascita mentre qui abbiamo a che fare con un’oligarchia per sussunzione. Però lo scollamento c’è, ed è percepito. Andava depurato dalla paccottiglia. Ci voleva un discorso serio che dicesse che non è vero che gli italiani sono meglio di chi li governa. Insomma un discorso serio di sinistra, credibile. Invece l’unica accusa che è stata contrapposta a Grillo è stata quella di demagogia e populismo. Il clamore nato dal nostro articolo è dovuto al fatto che invece di attaccarlo da destra l’abbiamo attaccato da sinistra. Io mi ricordo che quando ci fu per la prima volta l’Onda a Bologna, Grillo fu cacciato. Il V-Day era stato pochi mesi prima. Lui, nella sua grassa ignoranza, si presentò, e lo mandarono via.
A Pisa veniva cacciato anche chi aveva una bandiera di partito. L’impressione è che si parta sempre un po’ da zero. Non c’è mai, secondo me, una riflessione vera, per esempio sulle lotte ’99-’03. Si parla sempre del ‘900 ma è successo anche qualcosa dopo il ‘900.
 I movimenti saranno anche scemati ma la gente non è scomparsa. Il discorso relativo ai beni comuni ha cercato di recuperare i fili di quella narrazione, anche se il nodo rimane, quello dello scollamento. Si può dire, certo, che è un falso problema, si può essere radicalmente movimentisti, però è pur sempre vero che si presume che con quei movimenti tu le cose le voglia cambiare, voglia incidere in qualche modo. Io sono sempre stato abbastanza freddo davanti alle bandiere di partito ma non per questo credo si possa eludere il problema. A Bologna ora, per esempio, bisogna capire come si concretizzerà l’esperienza del referendum. Almeno una cosa dobbiamo riconoscerla: abbiamo fatto paura, la spallata gliel’abbiamo data. A queste oligarchie, voglio dire. E per ora è l’unico risultato pratico che è riuscito a ottenere Grillo: farle compattare e dimostrarne l’esistenza, mostrarne il funzionamento. Tendenzialmente però un movimento dovrebbe rompere, non compattare.
I movimenti saranno anche scemati ma la gente non è scomparsa. Il discorso relativo ai beni comuni ha cercato di recuperare i fili di quella narrazione, anche se il nodo rimane, quello dello scollamento. Si può dire, certo, che è un falso problema, si può essere radicalmente movimentisti, però è pur sempre vero che si presume che con quei movimenti tu le cose le voglia cambiare, voglia incidere in qualche modo. Io sono sempre stato abbastanza freddo davanti alle bandiere di partito ma non per questo credo si possa eludere il problema. A Bologna ora, per esempio, bisogna capire come si concretizzerà l’esperienza del referendum. Almeno una cosa dobbiamo riconoscerla: abbiamo fatto paura, la spallata gliel’abbiamo data. A queste oligarchie, voglio dire. E per ora è l’unico risultato pratico che è riuscito a ottenere Grillo: farle compattare e dimostrarne l’esistenza, mostrarne il funzionamento. Tendenzialmente però un movimento dovrebbe rompere, non compattare.
Tornando alla letteratura, ci incuriosiva sapere qualcosa di più a proposito della modalità del vostro essere scrittori. Mi riferisco da un lato al discorso del copyright, dall’altro a quello delle vostre apparizioni pubbliche. Essere una “band” di scrittori, fare delle “esibizioni dal vivo” è certamente qualcosa di nuovo per il panorama italiano: è attraverso questa modalità che promuoverete il vostro prossimo libro?
Il discorso riguarda la trasformazione del nostro mestiere. La crisi economica ha fatto crollare il potere d’acquisto dei nostri lettori, che in Italia già erano una minoranza. E questo, quello dell’analfabetismo, fondamentalmente, è un problema serio. Quando dichiari di difendere la scuola pubblica ti accusano di essere ideologico…ma in realtà stai difendendo il futuro. Noi siamo in un paese dove i lettori sono pochi e con la crisi sono diventati ancora meno. Lettori acquirenti, perlomeno. Si legge magari più frequentemente in rete: blog, social network… letteratura, meno. Il nostro mestiere dovrà cambiare, è nell’ordine delle cose. La nostra riflessione dunque è questa: nella storia della musica è successo che per alcuni anni – veramente pochi, se ci si pensa bene – l’industria discografica sia stata il volano del successo commerciale. Adesso però si deve tornare a suonare dal vivo, il pezzo registrato ha lo scopo di pubblicizzare il concerto. Noi non siamo dei musicisti ma la domanda che ci facciamo è: è possibile ripensarsi come cantastorie dal vivo? In altri paesi, in particolare nei paesi anglosassoni, addirittura si paga per assistere ad una presentazione. Lì gli autori affiancano alle royalties che ottengono dai diritti con le case editrici questo tipo di guadagno. Noi ci stiamo chiedendo se le attività portate avanti con Giap, che funge un po’ da collettore, non potrebbero diventare un po’ più organiche, accentrate. Si tratta di attività lavorative che potrebbero andare ad affiancare la narrazione pur continuando ad occuparsi di narrazione. Volendo provare a fare della narrazione un mestiere – artigianale ma pur sempre un mestiere – ci sono diverse vie che vanno tentate. Questo vale soprattutto per gli autori di medie dimensioni, come noi. Non abbiamo intenzione di fare passi indietro sulla politica del copyleft. Questo è un punto dirimente. Possiamo accettare la mediazione commerciale e avere un vincolo temporale – il testo disponibile gratuitamente un anno dopo – però in rete ce lo mettiamo. Poniamo il caso che le biblioteche fossero inventate oggi invece che nei tempi antichi. Se fossero state inventate dopo il copyright, ovvero lo sfruttamento intensivo del lavoro dell’ingegno, non sarebbero state inventate affatto. La biblioteca contraddice in maniera radicale tutti i principi liberisti che governano l’editoria planetaria. Noi riteniamo che non si torni indietro rispetto a questo. Ciò non significa che non si possano sperimentare varie cose: abbiamo fatto un e-book, ad esempio. Stiamo ragionando sulla possibilità di che il prossimo romanzo possa avere anche una versione e-book. Stiamo ancora studiando, ecco. Abbiamo ad esempio da poco attivato una funzione per le donazioni sul nostro sito. Se qualcuno normalmente scarica i nostri libri, gli può venir voglia di lasciarci qualche euro. È una forma di regalo reciproco. Per quanto invece riguarda l’andare in televisione, non si tratta di una questione ideologica, il punto è che non ci troviamo a nostro agio con quel mezzo di comunicazione. A noi piacciono i mezzi di comunicazione che implicano una reciprocità. Sia in rete, sia nelle presentazioni dal vivo, tu puoi avere un dialogo con il pubblico. La nostra assenza dalla televisione, inoltre, sottolinea a mio avviso quello che è un limite intrinseco della televisione come mezzo di comunicazione, cioè il suo essere tautologica. La televisione può parlare solo di se stessa, di ciò che ti mostra. Nulla vieterebbe di parlare dei nostri libri in nostra assenza. Che problema c’è? Ma no, l’assenza dell’autore fa sì che egli non possa essere comunicato. Perché in televisione viene comunicato il personaggio prima dell’opera e non c’è modo di disgiungere le due cose. Di conseguenza noi non esistiamo.
E vi dispiace?
Per una scuola di classe A. Il referendum di Bologna tra polemiche e strumentalizzazioni
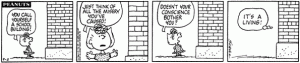 Il prossimo 26 maggio i cittadini bolognesi saranno chiamati ad esprimersi su un tema molto importante: la scuola. La città dovrà decidere, attraverso un referendum con valore consultivo, se finanziare con un milione di euro di soldi pubblici le scuole dell’infanzia paritarie. Questo aggettivo, “paritarie”, non deve condurre fuori strada: si tratta a tutti gli effetti scuole private. Il finanziamento del settore privato da parte del pubblico è un argomento molto dibattuto negli ultimi anni e questo rende immediatamente chiaro perché il referendum di Bologna non riguarda solo Bologna ed in gioco non ci sono soltanto le politiche educative di una città ma l’idea stessa di educazione e di società.
Il prossimo 26 maggio i cittadini bolognesi saranno chiamati ad esprimersi su un tema molto importante: la scuola. La città dovrà decidere, attraverso un referendum con valore consultivo, se finanziare con un milione di euro di soldi pubblici le scuole dell’infanzia paritarie. Questo aggettivo, “paritarie”, non deve condurre fuori strada: si tratta a tutti gli effetti scuole private. Il finanziamento del settore privato da parte del pubblico è un argomento molto dibattuto negli ultimi anni e questo rende immediatamente chiaro perché il referendum di Bologna non riguarda solo Bologna ed in gioco non ci sono soltanto le politiche educative di una città ma l’idea stessa di educazione e di società.
Schierati in campo ci sono il Comitato Articolo 33, promotore del referendum e a sostegno dell’impiego dei fondi per il finanziamento alla scuola pubblica, e l’amministrazione comunale, a maggioranza PD ma che nella crociata per il sostegno economico alle scuole private incontra il favore di PDL, Lega e Curia. Il percorso verso il referendum si è rivelato abbastanza accidentato, colpa soprattutto delle inottemperanze del sindaco Virginio Merola, che prima si è rifiutato di accorpare la data della consultazione alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio e successivamente ha predisposto un numero di seggi del tutto inadeguato ad accogliere quanti hanno il diritto di esprimere il proprio voto. Simili reticenze dimostrano una volta di più come gli interessi economici in ballo siano preponderanti e non del tutto trasparenti.
Dietro la maschera della convenienza si nascondono i sostenitori della cosiddetta “mozione B”, quella cioè a favore dell’erogazione del finanziamento alle scuole private, asserendo che senza il finanziamento in questione molti bambini rischierebbero di non poter frequentare le scuole dell’infanzia, dal momento che la stessa cifra investita nel pubblico non sarebbe sufficiente a soddisfare tutte le richieste. Lo spauracchio dell’esclusione dalla scuola dell’infanzia viene agitato per decretare l’irrinunciabilità dell’intervento pubblico nelle scuole private, in barba ad ogni etica.
 L’accusa per il comitato che difende la “mozione A”, quella per la scuola pubblica, laica e democratica, è di ideologismo: sostenere una questione di principio invece che assecondare la logica del mercato è oggi deprecabile più che calpestare la nostra Costituzione, la stessa dove è scritto che “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione” a patto che questi non comportino “oneri per lo Stato” (l’articolo in questione è il 33, che dà appunto il nome al comitato referendario). Con buona pace della Costituzione, tuttavia, questi oneri non sono mai mancati ed è vero che a Bologna le scuole “parificate” accolgono un gran numero di bambini.
L’accusa per il comitato che difende la “mozione A”, quella per la scuola pubblica, laica e democratica, è di ideologismo: sostenere una questione di principio invece che assecondare la logica del mercato è oggi deprecabile più che calpestare la nostra Costituzione, la stessa dove è scritto che “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione” a patto che questi non comportino “oneri per lo Stato” (l’articolo in questione è il 33, che dà appunto il nome al comitato referendario). Con buona pace della Costituzione, tuttavia, questi oneri non sono mai mancati ed è vero che a Bologna le scuole “parificate” accolgono un gran numero di bambini.
Ma il punto, noi crediamo, è un altro: non si tratta qui di dimostrare che cosa è più conveniente ma demolire quella stessa logica che nell’efficienza a tutti i costi vede il fine ultimo dell’istruzione e non un mezzo per la costruzione di cittadini liberi e critici. La scuola è un diritto. In questi tempi bui in cui anche i più elementari tra i diritti, come quello all’istruzione, al lavoro, alla salute, vengono gravemente minacciati dalla logica neoliberista è il caso di ribadirlo con forza: la scuola è un diritto. E un diritto è di tutti, non solo di qualcuno, per tutti uguale, indipendentemente dall’entità del conto in banca.
Il cardinale Bagnasco – lo ricorda Stefano Rodotà nel suo articolo pubblicato su Il Manifesto del 5 maggio scorso – ha dichiarato che optare per il finanziamento alle scuole private farebbe risparmiare allo Stato un bel po’ di soldi. Ma, osserva giustamente Rodotà, questa non è una questione di contabilità e, aggiungiamo noi, non è neanche una questione di legalità intesa come rispetto della Costituzione. La cifra della scommessa del referendum bolognese è molto più alta: quella dell’amministrazione comunale è una scelta politica, non solo economica, è la testimonianza dell’accettazione supina di un modello di sviluppo che vede nella cultura uno strumento pericoloso o comunque disprezzabile. Votare la mozione A non significa perciò soltanto difendere la scuola pubblica a Bologna, significa anche e soprattutto scegliere un modello di scuola che non sia schiava del mercato e del profitto ma gratuita e plurale. Una scuola in cui non ci si limiti a parlare di uguaglianza sociale ma la si pratichi ogni giorno.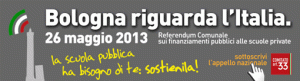
Raccontare per resistere. Le storie a margine della Storia
«In un angolo del campo di concentramento, a un passo da dove si innalzavano gli infami forni crematori, nella ruvida superficie di una pietra, qualcuno, chi?, aveva inciso con l’aiuto di un coltello forse, o di un chiodo, la più drammatica delle proteste: «Io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia».»
LUIS SEPÚLVEDA, Le rose di Atacama
 Il titolo del libro di Luis Sepúlveda pubblicato in italiano come “Le rose di Atacama” è “Historias marginales”, traducibile con “Storie marginali”. Storie a margine della Storia che si legano inestricabilmente ad essa e da essa non prescindono, ritratti di un’umanità dimenticata ma non distratta. Le storie marginali di cui racconta il grande scrittore cileno sono quelle degli uomini e delle donne incontrati nel corso dei viaggi che lo hanno portato in giro per il mondo, animato dalla voglia di avventura ma anche dal desiderio di fuggire da una dittatura – quella del generale Augusto Pinochet – che ha trasformato in incubi i sogni di una giovane generazione di cileni. A questa generazione appartengono molti degli amici le cui storie sono narrate da Sepúlveda, vittime di una violenza squallida in nessun caso più forte delle loro rivendicazioni e della loro resistenza. Come Lucas, un tal Lucas, come lo chiamano gli abitanti di Epuyén, studente argentino che trova in Patagonia un rifugio dall’orrore scatenato a metà degli anni ’70 da un altro dittatore, l’argentino Videla. Qui Lucas, insieme ad un gruppo di ragazzi e ragazze, studenti e artisti, si impegna per salvare gli alberi dalla furia distruttrice del “progresso” neoliberista, sostenendo l’elementare principio che la difesa della terra è la difesa degli esseri umani che la abitano. O come Fredy Taberna, nato nel deserto di Atacama, quasi sul confine fra il Cile e il Perù, che coltiva un umile amore per la bellezza selvaggia della propria terra e all’autore mostra lo spettacolo maestoso del deserto che solo per un giorno all’anno e solo per poche ore si ricopre di minuscoli fiori scarlatti. In quello stesso deserto Fredy incontra la morte nel settembre del 1973, pochi giorni dopo il golpe militare fascista, dichiarandosi colpevole di essere un militante socialista e cantando l’inno socialista a squarciagola. O come il professor Gálvez, morto lontano dalla propria patria per un destino crudele e mai compreso fino in fondo, e il sindacalista Vidal, a cui una foto di Greta Garbo dà la forza di sopportare i continui pestaggi.
Il titolo del libro di Luis Sepúlveda pubblicato in italiano come “Le rose di Atacama” è “Historias marginales”, traducibile con “Storie marginali”. Storie a margine della Storia che si legano inestricabilmente ad essa e da essa non prescindono, ritratti di un’umanità dimenticata ma non distratta. Le storie marginali di cui racconta il grande scrittore cileno sono quelle degli uomini e delle donne incontrati nel corso dei viaggi che lo hanno portato in giro per il mondo, animato dalla voglia di avventura ma anche dal desiderio di fuggire da una dittatura – quella del generale Augusto Pinochet – che ha trasformato in incubi i sogni di una giovane generazione di cileni. A questa generazione appartengono molti degli amici le cui storie sono narrate da Sepúlveda, vittime di una violenza squallida in nessun caso più forte delle loro rivendicazioni e della loro resistenza. Come Lucas, un tal Lucas, come lo chiamano gli abitanti di Epuyén, studente argentino che trova in Patagonia un rifugio dall’orrore scatenato a metà degli anni ’70 da un altro dittatore, l’argentino Videla. Qui Lucas, insieme ad un gruppo di ragazzi e ragazze, studenti e artisti, si impegna per salvare gli alberi dalla furia distruttrice del “progresso” neoliberista, sostenendo l’elementare principio che la difesa della terra è la difesa degli esseri umani che la abitano. O come Fredy Taberna, nato nel deserto di Atacama, quasi sul confine fra il Cile e il Perù, che coltiva un umile amore per la bellezza selvaggia della propria terra e all’autore mostra lo spettacolo maestoso del deserto che solo per un giorno all’anno e solo per poche ore si ricopre di minuscoli fiori scarlatti. In quello stesso deserto Fredy incontra la morte nel settembre del 1973, pochi giorni dopo il golpe militare fascista, dichiarandosi colpevole di essere un militante socialista e cantando l’inno socialista a squarciagola. O come il professor Gálvez, morto lontano dalla propria patria per un destino crudele e mai compreso fino in fondo, e il sindacalista Vidal, a cui una foto di Greta Garbo dà la forza di sopportare i continui pestaggi.
Ma le storie a margine della Storia di cui si popola il libro non hanno tutte per protagonisti eroi fieri e coraggiosi; ci sono atti di eroismo quotidiano più forti e dolorosi che meritano di essere tratti dal buio dell’oblio a cui la Storia – o l’Arte – li relega. È il caso dei cavatori di marmo di Pietrasanta, che ogni giorno sfidano la morte accarezzando la superficie liscia del marmo, sollevati con una corda a cento metri da terra con il sole che batte a picco sulla testa, in cerca di un punto in cui conficcare i loro pioli di ferro. I blocchi che ricavano dal marmo sono poi passati ai marmisti, che lavorano infaticabilmente ricoperti di polvere bianca e per i quali, al termine di una vita di duro lavoro, come ricompensa c’è solo la silicosi, o tisi dei marmisti, una malattia che a poco a poco pietrifica i polmoni. Questi anonimi costruttori di bellezza non lavorano per il successo, o per l’Arte, ma per il pane, per uno stipendio da portare a casa. I loro nomi non compaiono accanto a quello dell’artista sui monumenti che impreziosiscono i nostri giardini e le nostre piazze che però, come quasi tutte le cose belle, sono stati costruiti da operai poveri e dimenticati.
Dimenticati come la maggior parte di coloro che hanno vissuto l’Olocausto, ridotti a numeri due volte, prima dai nazisti e poi dalla Storia, con i suoi dati e le sue statistiche, condannati due volte all’oblio. Un oblio che il poeta ebreo Avrom Sutzkever cerca di combattere scrivendo versi dal ghetto in cui è confinato e facendoli avere a coloro che sono come lui prigionieri nei ghetti o, peggio, nei campi di sterminio. Infondere loro coraggio, un coraggio apparentemente privo di ragioni ma per questo ancora più necessario, sembra al poeta la miglior difesa contro l’orrore nazista. Perché di tutto si può privare un uomo tranne che della speranza.
 Senza mai perdere di vista il filo rosso che lega le storie con la minuscola alla Storia con la maiuscola, senza scadere in quella retorica della marginalità che della marginalità stessa fa un valore in sé, indipendentemente dalla coniugazione politica, Sepúlveda ci regala una galleria di immagini vive e nitide, mai banali o confezionate. Ancora una volta l’autore cileno emoziona e commuove con la sua prosa semplice e profonda al tempo stesso, condensando nelle poche righe di ciascun racconto una fortissima carica umana, ricca di immagini concrete ma anche di una potente valenza ideologica. Di natura diversa ma di uguale intensità è la passione che l’autore cileno mette nella descrizione delle balene del Mediterraneo e della lotta dei giornalisti contro il regime di Pinochet. “Lotta” è, a ben pensarci, una delle parole più ricorrenti nel testo: quella che Sepúlveda descrive non è però una lotta eroica, eccezionale, ma quotidiana, ordinaria, e per questo infinitamente più difficile e importante. Scriveva Bertold Brecht che ci sono uomini che lottano un giorno, altri che lottano un anno, altri ancora che lottano anni, ma di una categoria in particolare di uomini non possiamo fare a meno: sono quelli che lottano tutta la vita. A loro sono dedicate queste pagine, alle loro storie marginali, che come le rose di Atacama vivono solo un giorno, e solo per poco tempo, prima di essere spazzate via dalla sabbia della Storia. Ciò che a noi resta da fare è scavare sotto questa sabbia, e raccontare. Perché anche raccontare, come diceva il poeta João Guimarães Rosa, è resistere.
Senza mai perdere di vista il filo rosso che lega le storie con la minuscola alla Storia con la maiuscola, senza scadere in quella retorica della marginalità che della marginalità stessa fa un valore in sé, indipendentemente dalla coniugazione politica, Sepúlveda ci regala una galleria di immagini vive e nitide, mai banali o confezionate. Ancora una volta l’autore cileno emoziona e commuove con la sua prosa semplice e profonda al tempo stesso, condensando nelle poche righe di ciascun racconto una fortissima carica umana, ricca di immagini concrete ma anche di una potente valenza ideologica. Di natura diversa ma di uguale intensità è la passione che l’autore cileno mette nella descrizione delle balene del Mediterraneo e della lotta dei giornalisti contro il regime di Pinochet. “Lotta” è, a ben pensarci, una delle parole più ricorrenti nel testo: quella che Sepúlveda descrive non è però una lotta eroica, eccezionale, ma quotidiana, ordinaria, e per questo infinitamente più difficile e importante. Scriveva Bertold Brecht che ci sono uomini che lottano un giorno, altri che lottano un anno, altri ancora che lottano anni, ma di una categoria in particolare di uomini non possiamo fare a meno: sono quelli che lottano tutta la vita. A loro sono dedicate queste pagine, alle loro storie marginali, che come le rose di Atacama vivono solo un giorno, e solo per poco tempo, prima di essere spazzate via dalla sabbia della Storia. Ciò che a noi resta da fare è scavare sotto questa sabbia, e raccontare. Perché anche raccontare, come diceva il poeta João Guimarães Rosa, è resistere.
“Le rose di Atacama”, apparso per la prima volta nel 2000, è edito in Italia da Guanda e da TEA, giunta nel 2012 alla decima ristampa. La traduzione di entrambe le edizioni porta la firma di Ilide Carmignani. Luis Sepúlveda sarà presente il 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, dedicato quest’anno al Cile (www.salonelibro.it/salone/paese-ospite), ma non rappresenterà il suo paese, come ha dichiarato in una lettera indirizzata all’ambasciatore cileno in Italia. La decisione dello scrittore nasce dalla volontà di manifestare la propria solidarietà agli indigeni mapuche, da anni in lotta con il governo cileno per la riassegnazione delle loro terre. Le ragioni di Sepúlveda sono espresse dall’autore in un articolo pubblicato su Il Manifesto nel 2010, consultabile all’indirizzo http://www.ilmanifesto.it/archivi/fuoripagina/anno/2010/mese/09/articolo/3334/.
Dall’Onda allo Tsunami. Storia polemica di una cooptazione mancata e di una riuscita
La riflessione sul rapporto tra il M5S e la storia recente del movimentismo italiano non può prescindere dalle considerazioni dei Wu Ming apparse subito dopo le elezioni sul loro blog Giap. La tesi del collettivo bolognese, essenzialmente riassumibile nell’affermazione secondo la quale «Grillo cresce sulle macerie dei movimenti, gestendo lo spazio politico della rabbia popolare deviandola verso un bersaglio fittizio, la casta», risulta ai nostri occhi condivisibile anche se forse non sufficientemente contestualizzata. Abbiamo già avuto modo di parlare della prerogativa grillina di arrogarsi l’esclusiva sul patrocinio delle realtà movimentiste degli ultimi anni, una su tutte il NoTav, e tuttavia crediamo di non aver esaurito questo argomento. Siamo convinti infatti che una seria, profonda disamina della questione possa essere articolata solo avendo presente la storia dell’Onda, il movimento studentesco del 2008, la sua evoluzione e la sua dissoluzione.
Il 2008 è una data significativa sotto vari punti di vista. Nell’anno in cui è scoppiata la crisi globale dalla quale il nostro paese non sembra ancora accennare ad uscire, abbiamo assistito ad una delle proteste studentesche più massicce, anche se meno strutturate, degli ultimi decenni, che proprio a Pisa ha avuto uno dei suoi principali centri di irradiazione. Contemporaneamente, abbiamo visto nascere una proposta politica che ha a più riprese cavalcato l’onda del malcontento tirando le redini verso una declinazione impolitica delle rivendicazioni espresse dalla protesta (il primo V-Day risale al 2007). Ma il 2008 è anche l’anno della conclusione della fallimentare esperienza del governo Prodi ed è innegabile che i partiti di sinistra, primo fra tutti Rifondazione Comunista, da quell’esperienza sono usciti a pezzi, privi di credibilità e progettualità. A lungo si è discusso sulla “apoliticità” e sulla “apartiticità” dell’Onda e se da un lato si sono condannati con forza i tentativi della destra neofascista di infiltrare il movimento, rivendicando l’antifascismo come valore fondante, dall’altro l’affermazione secondo la quale la protesta era chiaramente e dichiaratamente “di sinistra” non ha incontrato una base altrettanto ampia di condivisione.
 In questo contesto la questione relativa alla “politicità” dell’Onda è stata dunque sommariamente liquidata tramite slogan, attraverso i quali si ribadiva la distanza del movimento da qualsivoglia forma di organizzazione politica e partitica, o meglio, è stata gestita in una chiave esclusivamente tattica, oltre che – se ci è permesso – di breve respiro e piccolissimo cabotaggio. Cerchiamo di spiegarci. I più attenti senz’altro ricorderanno lo slogan che più ha distinto quella fase oltre al celeberrimo “Noi la crisi non la paghiamo”: l’ossessivo e pervasivo “Non ci rappresenta nessuno”. Parole d’ordine di questo genere sembrano indubbiamente evocare un quadro vicino alle pratiche ed alla visione del mondo tipica dei movimenti antagonisti: alla rivolta contro i ceti dominanti che sembravano immuni agli effetti della crisi veniva affiancata la rivendicazione di una indipendenza programmatica e politica.
In questo contesto la questione relativa alla “politicità” dell’Onda è stata dunque sommariamente liquidata tramite slogan, attraverso i quali si ribadiva la distanza del movimento da qualsivoglia forma di organizzazione politica e partitica, o meglio, è stata gestita in una chiave esclusivamente tattica, oltre che – se ci è permesso – di breve respiro e piccolissimo cabotaggio. Cerchiamo di spiegarci. I più attenti senz’altro ricorderanno lo slogan che più ha distinto quella fase oltre al celeberrimo “Noi la crisi non la paghiamo”: l’ossessivo e pervasivo “Non ci rappresenta nessuno”. Parole d’ordine di questo genere sembrano indubbiamente evocare un quadro vicino alle pratiche ed alla visione del mondo tipica dei movimenti antagonisti: alla rivolta contro i ceti dominanti che sembravano immuni agli effetti della crisi veniva affiancata la rivendicazione di una indipendenza programmatica e politica.
Non è però così evidente come, nella composizione larga dell’Onda, che riuscì a politicizzare pezzi di panorama studentesco fino a quel momento estranei a qualsiasi forma di partecipazione e che ricevettero proprio in quel momento il primo imprinting politico, un tale discorso pubblico potesse risultare ambiguo, fraintendibile, poco digeribile e distinguibile dal quadro dominante della fase. Le letture possibili, e che in effetti agirono dentro il movimento, furono essenzialmente due, entrambe figlie di questo schema generale: la prima, propria dei “quadri” di movimento che avevano conosciuto un percorso politico prima dell’Onda, intendeva il “Noi la crisi non la paghiamo” come una sorta di manifesto anticapitalista del movimento, il suo bollino di qualità e di appartenenza all’area dell’antagonismo sociale, inequivocabilmente diretto contro gli istituti finanziari, la speculazione, e soprattutto le classi dominanti che stavano proteggendo i propri investimenti socializzando le perdite. Analogamente, il “Non ci rappresenta nessuno” era stato elaborato in particolare contro la sinistra dei partiti che avevano partecipato al fallimentare Governo Prodi, i quali avevano mancato proprio il bersaglio della rappresentanza istituzionale delle richieste dei movimenti della fase precedente.
Vi era però anche un aspetto ulteriore: nel contesto della nascita del “giustizialismo” o “grillismo” per come lo conosciamo oggi, i due slogan che veniamo analizzando sembravano affermare qualcosa di differente agli occhi entusiasti ma inesperti della composizione larga, un po’ impolitica ed in via di formazione che era la vera forza del movimento stesso, della sua capacità “d’urto” in tutte le piazze d’Italia. “Noi la crisi non la paghiamo” appariva lo slogan di una società omogenea in rivolta contro l’incapacità della “politica” di fornire risposte adeguate al crescente disagio. Contemporaneamente “Non ci rappresenta nessuno” mostrava in tutta la sua forza l’odio per la casta dominante, per una politica arroccata nel “palazzo” che parassitava una società impoverita con i suoi privilegi.
 Stiamo forse utilizzando in modo eccessivo le lenti dell’oggi, del post-elezioni 2013? Non lo crediamo, pensando allo sventolio delle cinque euro al grido di “Volete anche queste?” svoltosi di fronte al parlamento il 14 Novembre 2008, alle intimidazioni, viste anche a Pisa, contro chiunque portasse una bandiera in piazza, ed in generale al senso comune e all’aria che si respirava nelle manifestazioni e dentro il movimento. Ciò che si vuole affermare qui è però tutt’altro che una paternalistica dicotomia tra gruppi dirigenti e frange “esperte” contro entusiasmo ed ingenuità di un noviziato movimentista subalterno al discorso dominante. Anzi. La nostra tesi è infatti che buona parte di coloro che hanno materialmente fatto la linea politica nazionale dell’Onda abbiano provato a giocare sulla ambiguità fin qui descritta: la strategia di fondo di questi gruppi, di estrazione essenzialmente post-operaista e “negriana”, ha visto il tentativo di cooptare sotto un comune ombrello un consenso largo dalla strana natura giustizial-disobbediente, i cui nemici erano un po’ la casta, un po’ le classi dominanti, e certamente la sinistra politica. Il risultato, visto con gli occhi di oggi, parla però di un’altra cooptazione: la narrazione giustizialista, oggi grillina, forte non solo nel movimento dell’epoca, ma sui media e nella società, ha ricondotto buona parte di quel dissenso diffuso, confuso ma comunque presente, nella sfera d’influenza di quello che oggi è il M5S. Guardarsi bene dallo sciogliere le ambiguità, non per separare ma per chiarire e fare un passo avanti, ha così prodotto uno di quei classici passaggi tragici e ironici di cui sono fatte la storia e la politica: chi voleva cooptare è stato cooptato.
Stiamo forse utilizzando in modo eccessivo le lenti dell’oggi, del post-elezioni 2013? Non lo crediamo, pensando allo sventolio delle cinque euro al grido di “Volete anche queste?” svoltosi di fronte al parlamento il 14 Novembre 2008, alle intimidazioni, viste anche a Pisa, contro chiunque portasse una bandiera in piazza, ed in generale al senso comune e all’aria che si respirava nelle manifestazioni e dentro il movimento. Ciò che si vuole affermare qui è però tutt’altro che una paternalistica dicotomia tra gruppi dirigenti e frange “esperte” contro entusiasmo ed ingenuità di un noviziato movimentista subalterno al discorso dominante. Anzi. La nostra tesi è infatti che buona parte di coloro che hanno materialmente fatto la linea politica nazionale dell’Onda abbiano provato a giocare sulla ambiguità fin qui descritta: la strategia di fondo di questi gruppi, di estrazione essenzialmente post-operaista e “negriana”, ha visto il tentativo di cooptare sotto un comune ombrello un consenso largo dalla strana natura giustizial-disobbediente, i cui nemici erano un po’ la casta, un po’ le classi dominanti, e certamente la sinistra politica. Il risultato, visto con gli occhi di oggi, parla però di un’altra cooptazione: la narrazione giustizialista, oggi grillina, forte non solo nel movimento dell’epoca, ma sui media e nella società, ha ricondotto buona parte di quel dissenso diffuso, confuso ma comunque presente, nella sfera d’influenza di quello che oggi è il M5S. Guardarsi bene dallo sciogliere le ambiguità, non per separare ma per chiarire e fare un passo avanti, ha così prodotto uno di quei classici passaggi tragici e ironici di cui sono fatte la storia e la politica: chi voleva cooptare è stato cooptato.
La legge è uguale per tutti? Il caso Aldrovandi
 Ci sono fatti di cronaca che sfuggono ad una razionalizzazione, anche quando questa è più che mai necessaria. Quello che è successo mercoledì scorso a Ferrara non permette un’analisi, lucida o meno lucida. Alcuni rappresentanti del Co.I.S.P., il sindacato indipendente di polizia, hanno manifestato sotto le finestre del Comune di Ferrara per chiedere la scarcerazione degli agenti accusati dell’omicidio di Federico Aldrovandi. Paolo Forlani, Luca Pollastri ed Enzo Pontani si trovano attualmente in carcere, dove stanno scontando una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi, ridimensionata a soli 6 mesi grazie all’indulto. Monica Segatto è dal 18 marzo scorso agli arresti domiciliari, grazie al decreto svuota-carceri. Alle loro spalle uno striscione recita “La legge non è uguale per tutti. I poliziotti in carcere, i criminali a casa. Solidarietà, amicizia, speranza, affetto per Luca, Paolo, Monica, Enzo”. Luca, Paolo, Monica ed Enzo la notte del 25 settembre 2005 hanno picchiato a morte un ragazzo di 18 anni, Federico Aldrovandi, mentre stava tornando a casa. Dalle finestre del Comune di Ferrara, dove lavora, Patrizia Moretti assiste all’indecoroso spettacolo. Patrizia è la mamma di Federico. Che con un coraggio che non ha nulla di ordinario scende in strada con una foto del figlio massacrato, il volto insanguinato e tumefatto. La stessa foto, scattata in obitorio e inserita tra le prove del processo, che poche ore dopo Franco Maccari, segretario del Co.I.S.P., dichiarerà essere un fotomontaggio. Come si può conservare un atteggiamento lucido, razionale, di fronte all’empietà e all’arroganza del potere?
Ci sono fatti di cronaca che sfuggono ad una razionalizzazione, anche quando questa è più che mai necessaria. Quello che è successo mercoledì scorso a Ferrara non permette un’analisi, lucida o meno lucida. Alcuni rappresentanti del Co.I.S.P., il sindacato indipendente di polizia, hanno manifestato sotto le finestre del Comune di Ferrara per chiedere la scarcerazione degli agenti accusati dell’omicidio di Federico Aldrovandi. Paolo Forlani, Luca Pollastri ed Enzo Pontani si trovano attualmente in carcere, dove stanno scontando una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi, ridimensionata a soli 6 mesi grazie all’indulto. Monica Segatto è dal 18 marzo scorso agli arresti domiciliari, grazie al decreto svuota-carceri. Alle loro spalle uno striscione recita “La legge non è uguale per tutti. I poliziotti in carcere, i criminali a casa. Solidarietà, amicizia, speranza, affetto per Luca, Paolo, Monica, Enzo”. Luca, Paolo, Monica ed Enzo la notte del 25 settembre 2005 hanno picchiato a morte un ragazzo di 18 anni, Federico Aldrovandi, mentre stava tornando a casa. Dalle finestre del Comune di Ferrara, dove lavora, Patrizia Moretti assiste all’indecoroso spettacolo. Patrizia è la mamma di Federico. Che con un coraggio che non ha nulla di ordinario scende in strada con una foto del figlio massacrato, il volto insanguinato e tumefatto. La stessa foto, scattata in obitorio e inserita tra le prove del processo, che poche ore dopo Franco Maccari, segretario del Co.I.S.P., dichiarerà essere un fotomontaggio. Come si può conservare un atteggiamento lucido, razionale, di fronte all’empietà e all’arroganza del potere?
Il caso Aldrovandi non è sfortunatamente un caso isolato. Da Carlo Giuliani a Riccardo Rasman sono numerosi i nomi balzati negli ultimi anni agli onori della cronaca per avere in comune lo stesso triste, spietato destino: la morte incontrata per mano di coloro che, almeno secondo un certo senso comune, avrebbero dovuto difenderli e proteggerli. Di questo senso comune io non partecipo, il mio battesimo politico è stato nel sangue del G8 di Genova, il sangue di Carlo e dei ragazzi della Diaz. Chissà se la stessa innata diffidenza la condivideva Federico, mio coetaneo, quando quella maledetta notte del 25 settembre di 8 anni fa si trovava a camminare per viale Ippodromo e incontrava la volante Alfa 3 con a bordo gli agenti Pollastri e Pontani. Che cosa vide Federico? Questo non lo sapremo mai, quello che sappiamo è che sul posto poco dopo giunse la pattuglia Alfa 2 di Forlani e Segatto e l’intervento delle forze dell’ordine si concluse con due manganelli spezzati e un corpo senza vita a terra. Di quanto era successo la famiglia Aldrovandi venne informata solo alle 11 della mattina seguente e solo il 21 giugno 2012, dopo 7 anni di inquinamenti di prove e tentativi di depistaggio, si è arrivati ad una sentenza definitiva della corte di cassazione.
Giustizia è finalmente stata fatta, l’incubo è finito? Di pochi giorni fa è la notizia che, scontati i pochi mesi che gli restano di carcere, gli agenti condannati in via definitiva per l’omicidio colposo di Federico Aldrovandi potranno riprendere servizio. Dall’anno prossimo saranno di nuovo sulle strade, a garanzia della nostra sicurezza. L’ex ministro Giovanardi si felicita con loro definendoli vittime e dichiarando poi che quello dietro la testa di Federico non è sangue, bensì un cuscino. Patrizia Moretti lo querela mentre raccoglie la materna vicinanza di Laura Boldrini, il sostegno di Anonymous, che oscura il sito del Co.I.S.P., e soprattutto il calore della città di Ferrara, che scende in piazza per manifestare la propria solidarietà alla famiglia Aldrovandi e per chiedere, una volta di più: che altro si deve aver fatto più che uccidere a sangue freddo e senza ombra di pentimento un ragazzo indifeso per essere considerati criminali? Non resta che constatare, con amarezza, che lo striscione del Co.I.S.P. dice il vero: la giustizia non è uguale per tutti, i criminali sono a piede libero, detentori di un potere ingiusto, illimitato e impunito.
«Certo bisogna farne di strada
da una ginnastica d’obbedienza
fino ad un gesto molto più umano
che ti dia il senso della violenza
però bisogna farne altrettanta
per diventare così coglioni
da non riuscire più a capire
che non ci sono poteri buoni,
da non riuscire più a capire
che non ci sono poteri buoni.»
FABRIZIO DE ANDRÉ, Nella mia ora di libertà
C’eravamo tanto armati. Politica estera e spese militari
Grande assente di questa campagna elettorale è stata la politica estera. Nessuno si è pronunciato in merito, non una parola è stata spesa sui rapporti diplomatici con gli altri paesi europei o sul rifinanziamento delle missioni militari all’estero, quasi che non si potesse posare gli occhi al di fuori dei confini nazionali se non in un’ottica esclusivamente economica. L’unica eccezione sono state le sporadiche e in taluni casi controverse dichiarazioni a proposito dell’acquisto degli F-35, i cacciabombardieri dell’americana Lockheed Martin.
 Che il programma Joint Strike Fighter, questo il nome dell’operazione che ha come obiettivo la realizzazione dei velivoli, sia il più costoso programma militare a cui l’Italia abbia mai partecipato, con i suoi 15 miliardi di euro, è fuori discussione. L’acquisto di 131 aerei potrebbe costare al nostro paese, partner di primo livello insieme al Regno Unito, addirittura più di quanto preventivato: alcune stime parlano di una cifra compresa tra 25 e 40 miliardi di euro da mettere sul piatto nei prossimi 20 anni. Molte sono le industrie italiane più o meno direttamente coinvolte nell’affare, facenti perlopiù capo a Finmeccanica, l’azienda italiana che figura tra le 10 maggiori imprese produttrici di armi al mondo, conquistando l’ottavo posto con un fatturato di 14410 milioni di dollari. Ma si tratta dunque solo di questo, un affare a molti zeri?
Che il programma Joint Strike Fighter, questo il nome dell’operazione che ha come obiettivo la realizzazione dei velivoli, sia il più costoso programma militare a cui l’Italia abbia mai partecipato, con i suoi 15 miliardi di euro, è fuori discussione. L’acquisto di 131 aerei potrebbe costare al nostro paese, partner di primo livello insieme al Regno Unito, addirittura più di quanto preventivato: alcune stime parlano di una cifra compresa tra 25 e 40 miliardi di euro da mettere sul piatto nei prossimi 20 anni. Molte sono le industrie italiane più o meno direttamente coinvolte nell’affare, facenti perlopiù capo a Finmeccanica, l’azienda italiana che figura tra le 10 maggiori imprese produttrici di armi al mondo, conquistando l’ottavo posto con un fatturato di 14410 milioni di dollari. Ma si tratta dunque solo di questo, un affare a molti zeri?
L’F-35 è un aereo da combattimento di quinta generazione, ottimizzato per l’attacco e in grado di accogliere nelle due stive interne anche ordigni nucleari. Viene da chiedersi a che cosa serva un giocattolo come questo ad una nazione che “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Per l’Art. 11 della Costituzione Italiana vale ciò che Giovenale diceva a proposito della virtù: laudatur et alget, da tutti è lodato ma muore di freddo. L’Italia infatti è un paese in guerra e lo è da oltre 10 anni, da quando, per l’esattezza, è entrata a far parte dell’operazione Enduring Freedom, lanciata dagli Stati Uniti contro l’Afghanistan in risposta agli attentati dell’11 settembre 2001. Nonostante quattro governi si siano succeduti da allora e nonostante le condizioni economiche siano profondamente mutate, a tirarsi fuori dall’Afghanistan, da una guerra estremamente dispendiosa sia in termini economici che in termini di vite umane, nessuno ha mai pensato.
Anzi. A fronte di una leggera flessione europea dovuta all’impatto delle misure di austerity, il trend mondiale non ha registrato inversioni di rotta, evidenziando una sostanziale stabilità della spesa militare, che si attesta sul 2,5% del PIL globale, con un costo medio di 249 dollari per abitante del pianeta. Anche in Italia, in controtendenza con tutti gli altri comparti della spesa pubblica, la Difesa non ha subito tagli significativi. Peccato non poter dire la stessa cosa della sanità. Le cifre ufficiali parlano di circa 23 miliardi di euro per l’anno 2011 ma il dato risulta abbastanza discutibile perché non tiene conto di tutti quei finanziamenti che vengono rubricati sotto altre voci ma che di fatto confluiscono nelle spese militari. Ad esempio, quelli a Finmeccanica. Realisticamente, la cifra di cui stiamo parlando si aggira intorno ai 32 miliardi di dollari. Ma non si tratta solo di numeri.
 Quando si parla di investimenti militari, smarcarsi da un punto di vista sordidamente economico è difficile. Molti studi indipendenti che sottolineano l’importanza della riconversione mettono a punto analisi puntuali e dettagliate e senza dubbio il tentativo di dimostrare i benefici derivanti da un passaggio dal warfare al welfare merita di essere premiato. Ad esempio, forse non tutti sanno che a fronte di un investimento di 1 miliardo di dollari sono 11mila i posti di lavoro che si creano nel settore della difesa contro i 29mila nel settore dell’istruzione. Il punto però è che non si tratta solo di una questione economica: ciò che serve è una prospettiva che esuli dal dato statistico. In altre parole, se disarmare l’economia e riconvertirla non fosse la strada più conveniente, sarebbe in ogni caso quella da percorrere. Mai come in questo momento. La crisi che ha investito produzioni e consumi deve essere la molla che fa scattare la riflessione sul nostro modello di sviluppo, di cui la corsa agli armamenti costituisce un aspetto preponderante. Questo modello deve essere abbandonato. Perché è giusto, prima ancora che necessario.
Quando si parla di investimenti militari, smarcarsi da un punto di vista sordidamente economico è difficile. Molti studi indipendenti che sottolineano l’importanza della riconversione mettono a punto analisi puntuali e dettagliate e senza dubbio il tentativo di dimostrare i benefici derivanti da un passaggio dal warfare al welfare merita di essere premiato. Ad esempio, forse non tutti sanno che a fronte di un investimento di 1 miliardo di dollari sono 11mila i posti di lavoro che si creano nel settore della difesa contro i 29mila nel settore dell’istruzione. Il punto però è che non si tratta solo di una questione economica: ciò che serve è una prospettiva che esuli dal dato statistico. In altre parole, se disarmare l’economia e riconvertirla non fosse la strada più conveniente, sarebbe in ogni caso quella da percorrere. Mai come in questo momento. La crisi che ha investito produzioni e consumi deve essere la molla che fa scattare la riflessione sul nostro modello di sviluppo, di cui la corsa agli armamenti costituisce un aspetto preponderante. Questo modello deve essere abbandonato. Perché è giusto, prima ancora che necessario.
Orestea civile. Una tragedia elettorale
Più che al “Che fare?” di černyševskijana memoria è forse il caso di rivolgersi, in vista delle prossime elezioni politiche, all’oresteo “Che cosa debbo fare?”. Perchè la questione, ne è convinta chi scrive, è prima di tutto morale.
Chi, come me, ha sempre provato un brivido lungo la schiena di fronte alle tante, troppo lapidi commemorative nei cimiteri e nelle piazze d’Italia che ricordano come molti ragazzi e ragazze hanno dato la vita per liberare l’Italia dal nazifascismo e per permettere a noi, oggi, di mettere una croce a matita su una scheda, non può non trovarsi in imbarazzo di fronte alle dichiarazioni di non voto, nutrendo una malcelata antipatia nei confronti di coloro che, lamentando una reale mancanza di alternative, si sono a più riprese tenuti lontani dalle urne. Eppure, stavolta, anche le più granitiche, epidermiche certezze si sgretolano di fronte alle alternative che abbiamo davanti. La ragione, è presto detta: l’odiosa formula coniata da Montanelli nel 1976 per legittimare il voto alla DC in chiave anticomunista, “turarsi il naso”, per la prima volta non appare così inappropriata.
Occamisticamente, non dovremmo incontrare grandi difficoltà nel tagliare fuori dal ventaglio di possibilità tutti quei partiti (PD in primis) che hanno sposato dogmaticamente la causa del pareggio di bilancio. Il sì al Fiscal Compact, di cui più diffusamente e tecnicamente si parla in altre pagine di questo giornale, è forse un discrimine più attuale e determinante della dicotomia destra-sinistra per comprendere le posizioni delle varie coalizioni. Al pari di una cartina al tornasole, la volontà di rispettare gli impegni presi in sede europea la dice lunga sulle effettive priorità di un’eventuale compagine governativa. In modo analogo, le motivazioni della squalifica di Grillo e del suo M5S dalle possibili opzioni sono state in modo molto chiaro e del tutto condivisibile analizzate dal nostro Francesco Marchesi nel precedente numero. Che cosa resta dunque? Poco o niente altro, ad eccezione della Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia, rispetto alla quale è perciò doveroso porsi alcuni interrogativi.
Innanzitutto, la posizione del movimento guidato dal magistrato palermitano a proposito della rinegoziazione del debito, opposta a quella del PD, non può non apparire come un elemento positivo. Il no netto al Fiscal Compact è il primo punto del programma di RC e questo è indubbiamente un dato incoraggiante. Anche perché, in questa direzione, sono davvero pochissime le voci che si levano a sostegno dell’idea (e dell’esigenza) di un’alternativa alle logiche di potere, economico in primo luogo, che costringono il nostro paese nella morsa dell’austerità. La domanda che sorge spontanea è perciò: era davvero necessario che queste cose venissero a raccontarcele intellettuali provenienti dalla società civile? Il tentativo, mai del tutto compiuto e comunque disconosciuto da alcuni suoi fautori (come il sociologo Luciano Gallino), di dar vita ad un’opposizione di governo che non avesse con i partiti che un legame addizionale appare tanto incomprensibile quanto inefficace. Come si può bollare, come Antonio Ingroia ha fatto, La Sinistra – L’arcobaleno come un’accozzaglia di forze politiche etichettando invece RC come movimento autonomo a cui i partiti hanno aderito senza essere vittime della stessa retorica antipolitica con la quale Grillo ammannisce, come Berlusconi prima di lui, le piazze italiane? Si è scommesso sulla forma invece che sui contenuti e il messaggio che si è fatto passare non è stato “Noi siamo alternativi agli altri perché pensiamo cose diverse da loro!”, bensì “Noi siamo alternativi agli altri perché siamo diversi da loro!”. Prova ne sia la scelta di alcuni dei candidati di maggiore spicco, selezionati in base ad un criterio di popolarità, per i cognomi “illustri” (è il caso di Ilaria Cucchi) o per essere già noti al grande pubblico (come Sandro Ruotolo).
Ma dietro questa evidente concessione alla politica-spettacolo si nasconde probabilmente dell’altro: le forche caudine elettorali hanno spinto realtà molto diverse tra loro, dai comitati referendari di ALBA prima e di Cambiare si può poi a Rifondazione Comunista, passando per IdV e PdCI a ripararsi (è il caso di dirlo) sotto lo stesso ombrello, nel tentativo, più o meno dichiarato, di fare fronte comune contro l’avanzata dell’asse montiano. In quest’ottica il no al Fiscal Compact può essere più banalmente interpretato come elemento aggregante, collante debole ma necessario al frontismo che sta alla base di una convivenza forzata. Viene da chiedersi, a questo proposito, se non sia forse proprio questa la ragione per la quale è alla componente “comunista” della coalizione che si è appaltato il discorso relativo alla materia economica: per una sostanziale mancanza di interesse da parte dell’anima della società civile o, peggio ancora, per una reale incapacità di affrontare l’argomento. Quel che è certo è che il Giano bifronte che si presenta agli elettori è del tutto privo di un’identità definita o anche solo elaborata, col risultato che sono più le perplessità che suscita che gli entusiasmi.
 E se è al nicodemismo che si deve attribuire una certa tendenza ad abbracciare acriticamente la convinzione che ciò che conta non sono le idee ma le persone, la preoccupazione che neanche il ventennio berlusconiano sia riuscito a mettere in guardia dai rischi di una spettacolarizzazione della lotta politica non è del tutto dissipata. Puntualmente, per vanità o nel tentativo di corteggiare le parti basse dell’elettorato, si ricade nell’errore di scrivere a caratteri cubitali sul simbolo elettorale il nome del candidato premier. In questo caso, il magistrato Ingroia, qualifica che purtroppo offre già di per sé il fianco a critiche e strumentalizzazioni provenienti da ogni parte. Se infatti il partito di un altro magistrato, l’IdV di Antonio Di Pietro, è stato l’unico a fare opposizione in Parlamento al governo tecnico, il secondo punto del programma di RC, la difesa della legalità e la lotta alla mafia, ci propone una volta di più una sinistra prigioniera del giustizialismo. In un’intervista successiva al suo intervento all’assemblea del teatro Quirino, Ugo Mattei critica Ingroia su questo punto, accusandolo di guardare al ripristino della statualità come panacea di ogni male e all’ottica rigidamente legalista di quest’ultimo oppone quella che definisce come un’illegalità creativa e costituente. Si tratta di uno spunto che ci aiuta a rimarcare la distanza che c’è tra legalità e giustizia: l’evasione fiscale è esecrabile ma fare scempio legalmente della scuola e della sanità pubbliche lo è di più. In altre parole, ha senso difendere a tutti i costi la legalità se la legge è fatta di leggi ingiuste? La giustizia civile non può esistere senza giustizia sociale, senza la quale, a sua volta, non ci sono le premesse per costruire una società giusta.
E se è al nicodemismo che si deve attribuire una certa tendenza ad abbracciare acriticamente la convinzione che ciò che conta non sono le idee ma le persone, la preoccupazione che neanche il ventennio berlusconiano sia riuscito a mettere in guardia dai rischi di una spettacolarizzazione della lotta politica non è del tutto dissipata. Puntualmente, per vanità o nel tentativo di corteggiare le parti basse dell’elettorato, si ricade nell’errore di scrivere a caratteri cubitali sul simbolo elettorale il nome del candidato premier. In questo caso, il magistrato Ingroia, qualifica che purtroppo offre già di per sé il fianco a critiche e strumentalizzazioni provenienti da ogni parte. Se infatti il partito di un altro magistrato, l’IdV di Antonio Di Pietro, è stato l’unico a fare opposizione in Parlamento al governo tecnico, il secondo punto del programma di RC, la difesa della legalità e la lotta alla mafia, ci propone una volta di più una sinistra prigioniera del giustizialismo. In un’intervista successiva al suo intervento all’assemblea del teatro Quirino, Ugo Mattei critica Ingroia su questo punto, accusandolo di guardare al ripristino della statualità come panacea di ogni male e all’ottica rigidamente legalista di quest’ultimo oppone quella che definisce come un’illegalità creativa e costituente. Si tratta di uno spunto che ci aiuta a rimarcare la distanza che c’è tra legalità e giustizia: l’evasione fiscale è esecrabile ma fare scempio legalmente della scuola e della sanità pubbliche lo è di più. In altre parole, ha senso difendere a tutti i costi la legalità se la legge è fatta di leggi ingiuste? La giustizia civile non può esistere senza giustizia sociale, senza la quale, a sua volta, non ci sono le premesse per costruire una società giusta.
Ci si potrebbe allora chiedere anche se sia corretto parlare di sinistra in riferimento a realtà come Cambiare si può e il Movimento Arancione di Luigi De Magistris (un altro magistrato). L’esperienza de La Sinistra – L’arcobaleno non è in questo senso paragonabile a quella di RC, che di queste realtà costituisce l’approdo. In quel caso, anche se ovattato, un riferimento alla sinistra c’era e a rappresentare il partito in televisione e sui giornali era uno storico leader della sinistra italiana come Fausto Bertinotti. Certo, i compromessi erano stati tali e tanti da rendere legittimo il dubbio che ne fosse valsa la pena ma in questo caso ogni riferimento ad una tradizione politica – diciamolo pure – comunista sembra addirittura scomparso, spazzato via come polvere sotto il tappeto. Chi pensava che il PD avesse intrapreso da solo la strada della damnatio memoriae dovrà a malincuore constatare che Bersani e compagni (si fa per dire) hanno degli alleati in questa vile crociata. Le parole, ricordava Nanni Moretti nella celebre scena di Palombella rossa, sono importanti. Perché allora espungere ogni riferimento non solo al comunismo ma anche alla sinistra dal logo e dal nome di RC? Mi si dirà che anche in questo caso si tratta di un vizio di forma, di una necessità nicodemitica, e che ciò che conta sono, una volta di più, i contenuti. Ma un conto è darsi una patina di appeal mediatico rinunciando a parte della propria identità, come era stato per La Sinistra – L’arcobaleno, un conto è sradicarsi da una tradizione alla quale in fondo non si sente neppure di appartenere o della quale si è arrivati a vergognarsi, e da ben prima di quest’appuntamento elettorale.
Il punto, io credo, è proprio questo. Per quanti possano essere gli sforzi di Ingroia e della sua RC, ciò che manca a questa operazione è una prospettiva un po’ più ampia di quella che può dare un programma elettorale, per quanto condivisibile nei suoi passaggi fondamentali. Delle radici un po’ più profonde, che non affondino soltanto nella storia personale, forte, interessante, dei candidati. Il comunismo, diceva Rossana Rossanda, ha sbagliato ma non è sbagliato. È ora che chi crede ancora nella rappresentanza parlamentare faccia i conti, una volta per tutte, con questo giudizio. Solo allora noi elettori saremo liberi dal dubbio di Oreste, la tragica scelta tra libertà e necessità.
«Non sono mai stata populista: non lo può essere chi è venuto alla politica dal rifiuto del fascismo. Avevo visto il poveraccio fascista, quello che si era messo nelle milizie nel 1944 perché non sapeva dove andare. Conoscevo al sud chi si faceva carabiniere o seminarista per necessità ma diventava poi molto carabiniere e molto seminarista. Le scelte prima le facciamo poi ci fanno.»
ROSSANA ROSSANDA, La ragazza del secolo scorso
Vuote rosa. Le donne e la politica
 Nel recente confronto televisivo che ha visti schierati i candidati alle primarie del centrosinistra, Laura Puppato ha chiesto agli elettori – anche se forse sarebbe più corretto dire alle elettrici – di votarla perché donna. In effetti, numerosi sono i comitati che hanno sostenuto la candidatura della consigliera regionale del Veneto proprio sulla base dell’identità sessuale (uno su tutti “Donne per Laura Puppato”), lamentandone tuttavia la scarsa visibilità televisiva, significativamente ribattezzata “burqa mediatico”. Le “quote rosa”, riferimenti all’attualità a parte, rappresentano un tema che negli ultimi anni è stato lungamente dibattuto e rispetto al quale le posizioni solitamente prescindono dall’area politica di appartenenza. Che l’unica candidata donna alle primarie, come ogni articolo e servizio ha descritto la Puppato nelle ultime settimane, sottolinei lei stessa il proprio genere come se si trattasse di una nota di merito, non può non far riflettere.
Nel recente confronto televisivo che ha visti schierati i candidati alle primarie del centrosinistra, Laura Puppato ha chiesto agli elettori – anche se forse sarebbe più corretto dire alle elettrici – di votarla perché donna. In effetti, numerosi sono i comitati che hanno sostenuto la candidatura della consigliera regionale del Veneto proprio sulla base dell’identità sessuale (uno su tutti “Donne per Laura Puppato”), lamentandone tuttavia la scarsa visibilità televisiva, significativamente ribattezzata “burqa mediatico”. Le “quote rosa”, riferimenti all’attualità a parte, rappresentano un tema che negli ultimi anni è stato lungamente dibattuto e rispetto al quale le posizioni solitamente prescindono dall’area politica di appartenenza. Che l’unica candidata donna alle primarie, come ogni articolo e servizio ha descritto la Puppato nelle ultime settimane, sottolinei lei stessa il proprio genere come se si trattasse di una nota di merito, non può non far riflettere.
Se da un lato infatti le quote rosa, quote minime di partecipazione femminile alla vita istituzionale, sono viste come un male necessario in un paese in cui vent’anni di berlusconismo hanno generato grotteschi stereotipi sul ruolo della donna, dall’altro è difficile instaurare un dibattito sull’argomento che esuli da pregiudizi e abbia solide basi concettuali. Il nocciolo della questione sta probabilmente in ciò che si intende per “genere”. Essere donna è a quanto pare bastevole per ottenere la fiducia degli elettori. Il genere conferisce perciò un valore aggiunto alle proprie argomentazioni, finendo in alcuni casi addirittura per sostituirvisi. Eppure, se Vendola avesse concluso il proprio discorso rimarcando la sua distanza degli altri candidati in quanto unico candidato omosessuale, stupore misto a indignazione avrebbe pervaso le file del pubblico. E lo stesso forse sarebbe avvenuto se, alla vigilia della sua rielezione, Obama si fosse rivolto al popolo americano dicendo: “Votatemi, sono nero!”. Perché allora non ci stupisce che una donna svuoti di contenuti la discussione riducendola ad una mera questione sessuale?
Recentemente Vladimir Luxuria ha commentato il dibattito sulla presenza femminile in politica paragonando le quote rosa alla legge che impone l’assunzione di persone svantaggiate (invalidi, tossicodipendenti, condannati) nelle cooperative sociali. L’intento voleva essere provocatorio ma che le donne in Parlamento abbiano una posizione subalterna rispetto ai colleghi maschi è un dato di fatto, come dimostrano non solo e non tanto i numeri quanto determinate dinamiche. Negli ultimi anni le donne che hanno ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana sono state quasi sempre prive del cosiddetto “portafoglio”? Si pensi al IV Governo Berlusconi, nel quale solo Mariastella Gelmini e Stefania Prestigiacomo, rispettivamente ministri dell’Istruzione e dell’Ambiente, avevano a disposizione dei fondi. Fondi che, tuttavia, erano destinati ad essere drasticamente ridotti. Non è un caso. È una pratica diffusa infatti quella di affidare a donne ruoli che sovrintendono a feroci tagli di bilancio. O a irrilevanti questioni etiche.
Si prenda a titolo d’esempio il dibattito che portò al referendum sulla fecondazione assistita del giugno 2005: in quell’occasione Rosy Bindi e Stefania Prestigiacomo, allora ministro per le Pari Opportunità, offrirono a reti unificate un ritratto piuttosto pietoso della rappresentanza politica femminile. Attacchi personali e offese gratuite resero quel confronto, perpetuatosi di talk show in talk show, uno spettacolo che, al di là del merito della questione, di edificante aveva poco o nulla. Non sarebbe bastato tuttavia un maggior fair play a renderlo meno patetico, dal momento che nasceva con un vizio di forma. Qualche brillante maître à penser deve aver avuto l’idea: “Fecondazione assistita? Chi meglio di due donne per parlarne in TV!”. Il risultato deludente lo si deve proprio a questa logica perversa, secondo la quale non conta tanto ciò che si ha da dire quanto ciò che si è o si rappresenta.
Frutto della medesima logica sono le quote rosa, che ben lungi dal colmare un deficit di rappresentanza e appianare le disparità tra generi ingabbiano la partecipazione femminile in forme ipostatizzate e ne fanno in alcuni casi addirittura un imbarazzante cliché. Se a capo degli enti pubblici e ai vertici delle aziende private le donne sono poche è perché l’Italia è un paese fondamentalmente privo di un sistema di welfare che consenta di conciliare la dimensione professionale con quella familiare, costringendo nella maggior parte dei casi le donne ad una scelta tra l’una e l’altra.
E non c’entra, come qualcuno potrebbe pensare, la meritocrazia. Asserire che il ruolo che faticosamente arrivano a ricoprire le donne devono meritarselo è sbagliato quasi quanto proclamarsi a favore delle quote rosa, in base alle quali esse si ritroverebbero ad occupare posizioni indipendentemente dalle loro reali inclinazioni o attitudini. Purtroppo l’arretratezza socio-economica dell’Italia non consente una gara ad armi pari. Per questo parlare di merito appare fuori luogo: non si tratta di mettere in discussione la preparazione e la competenza delle candidate di sesso femminile, bensì la possibilità che queste si rivelino senza essere svilite da una soluzione inefficace e a tratti umiliante – le quote rosa, appunto –, che non mira a risolvere i problemi strutturali alla base di una disparità congenita ma si accontenta, per così dire, di metterci una pezza.
Il nodo gordiano della questione sta, a parer mio, nell’impossibilità di una risoluzione strutturale che non abbia declinazioni politiche. La fallimentare esperienza di “Se non ora quando?”, il movimento nato intorno alla manifestazione del 13 febbraio, lo dimostra chiaramente. Il gruppo di donne “diverse per età, professione, provenienza, appartenenza politica e religiosa” che forma il comitato promotore guarda alla trasversalità come a una ricchezza. Ma l’apertura a cui si fa riferimento è in questo caso sinonimo di ambiguità: una mancanza di basi politiche che rischia di spalancare le porte a discutibili prese di posizione come quelle della Santanchè con il suo femminismo antislamico.
Personalmente, ritengo che nessuna rivendicazione di genere abbia senso a meno che non sia inserita in un contesto politico che si faccia carico di agire sulle cause strutturali della disparità tra individui, a qualunque categoria essi appartengano. Non m’importa che il ministro per le Pari Opportunità sia una donna, se non è in grado di ripensare una società che annulli la dipendenza economica delle vittime di abusi domestici. Mi piacerebbe piuttosto veder occupare quel posto ad un uomo che si sia espresso chiaramente su temi come l’aborto e il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Questo perché credo che lo stato di cose esistenti possa essere rovesciato solo da una presa di posizione tout court, che non accetti compromessi e non agisca sulla base di istanze depauperate di contenuti, svilite dalla mancanza di argomentazioni, prive di radici politiche. In una parola: vuote.
La ragazza con il vestito azzurro o il Riscatto
Questo è il primo dei nove articoli che tra il 2012 e il 2013 sono apparsi sul mensile Quote Rosse a mia firma. Non essendo più online il sito della rivista, ho deciso di ripubblicarli qui, per dare la possibilità a chi fosse interessato di consultarli. Buona lettura.
 «La ragazza vestita di azzurro sembrava non sapere nulla di quello che accadeva nel palazzo. Continuava a scendere le scale come un’ombra fra gli uomini sudati. Per Linda, però, ognuno di quei fatti aveva un significato e le insegnava qualcosa di più, molto di più, di quanto le insegnavano i libri che leggeva durante la notte.»
«La ragazza vestita di azzurro sembrava non sapere nulla di quello che accadeva nel palazzo. Continuava a scendere le scale come un’ombra fra gli uomini sudati. Per Linda, però, ognuno di quei fatti aveva un significato e le insegnava qualcosa di più, molto di più, di quanto le insegnavano i libri che leggeva durante la notte.»
JORGE AMADO, Sudore
Salvador di Bahia, 1934. Anzi, non è esatto. Ladeira do Pelourinho, 1934. Numero 68 (numero profetico?). Un microcosmo è un microcosmo e va trattato come tale. Poco importa dove si trova. A dire il vero, poco importa anche quando si trova, se non per chiarire la cornice che va da sfondo alle vicende. Anche se, in questo caso, di vicende forse non si può neanche parlare. Nulla sembra cambiare nelle poco più di 100 pagine che compongono il capolavoro di Amado (ma ogni libro dello scrittore brasiliano è tale). Tranne un dettaglio. Prima però occorre fare un passo indietro.
Ladeira do Pelourinho, dicevamo. 1934. Numero 68, un palazzo di quattro piani. 116 locali in cui abitano circa 600 persone. I loro nomi, poco importa. È il palazzo stesso il protagonista del romanzo, creatura vivente e proteiforme dalle mille anime ma dall’unico cuore pulsante. Al suo interno, nei locali sporchi e maleodoranti, si fa la conoscenza di un campionario piuttosto variopinto di miserie umane.
Circondata dalla puzza di piedi c’è dona Risoleta, che infaticabile lavora alla macchina da cucire per mantenere Linda, la figlioccia, alla quale augura un destino migliore del proprio: il matrimonio con un ricco, con un padrone. C’è la tisica che occupa il solaio, coi i suoi colpi di tosse sembra stia per rendere da un momento all’altro l’anima al Creatore. Ci sono il professor Otávio, che dal dolore per la perdita della moglie e della figlia ha perso anche la ragione, e Cabaça, il mendicante, che si prende cura dei topi con i quali condivide l’angusto spazio del sottoscala. Nell’afa soffocante del pomeriggio si incontrano per le scale il negro Henrique, Julieta, Prendi-e-castra, una delle tante Marie senza padre e senza cognome che si guadagna da vivere al prezzo della propria dignità.
E poi, senza che il narratore ce ne descriva le miserie, compare una figura femminile. Scompare una figura femminile, apparizione fugace che scende leggera le scale inondate dal puzzo di piscio. Ha un vestito azzurro, nient’altro ci viene detto. Chi è costei che non sembra far parte della tragedia corale che Amado descrive? Non sembrano toccarla le tristi sorti dei coinquilini, neppure l’arresto dell’ebreo Isaac, neppure l’uccisione di Álvaro Lima, colpito da una pallottola in mezzo alla fronte mentre grida “Proletari di tutto il mondo, unitevi!”.
La ragazza col vestito azzurro (neanche lei ha un nome) ha trovato il suo Riscatto, e lo racconta a Linda, che incontra a metà delle scale. Sposerà il suo padrone, entrerà a far parte dell’alta società. Linda, i manifesti sotto il braccio, la guarda, sorride dolcemente. La Storia, qualunque cosa accada, è dalla sua parte.
 Ma di quale Storia stiamo parlando? “Sudore”, terzo romanzo dell’allora ventiduenne (eh sì) Jorge Amado, definito dall’autore stesso come “quaderno d’apprendistato di un romanziere”, è prima di tutto un dito puntato contro la Storia, quella universale, quella che si trova sui libri, quella per la quale le storie (con la minuscola) esistono solo se servono a cementificare date e nomi già usati, già noti. Ma il cantore di Bahia ha la radicata convinzione che non ci sia bisogno di grandi numeri per fare la Storia, che una storia singola, semplice (banale?), sia sufficiente per cambiare equilibri e punti di vista.
Ma di quale Storia stiamo parlando? “Sudore”, terzo romanzo dell’allora ventiduenne (eh sì) Jorge Amado, definito dall’autore stesso come “quaderno d’apprendistato di un romanziere”, è prima di tutto un dito puntato contro la Storia, quella universale, quella che si trova sui libri, quella per la quale le storie (con la minuscola) esistono solo se servono a cementificare date e nomi già usati, già noti. Ma il cantore di Bahia ha la radicata convinzione che non ci sia bisogno di grandi numeri per fare la Storia, che una storia singola, semplice (banale?), sia sufficiente per cambiare equilibri e punti di vista.
Direttamente dall’esperienza biografica (lo stesso Amado, a 16 anni, aveva respirato l’odore acre del Sudore al numero 68 della Ladeira do Pelourinho) nasce questo documento incredibile, a metà tra il pamphlet e il Bildungsroman, che a sua volta vive un’esistenza abbastanza travagliata, finendo addirittura con l’essere bruciato in piazza nel 1937 per mano della polizia dell’Estado Novo, la dittatura fascista che Getùlio Vargas instaurò in Brasile tra il ’37 e il ’45. A questa Storia, cattiva e ottusa, Amado oppone quello che è prima di tutto un messaggio di speranza: se il testo ha infatti la lucidità della denuncia e la verità della testimonianza, esso è prima di tutto una parabola sul riscatto.
All’uccisione di Álvaro Lima, e all’arresto degli altri compagni che con lui avevano organizzato lo sciopero, fa seguito uno sdegno per la prima volta carico non più di cieca rassegnazione di fronte alle forze troppo grandi della Storia ma di una volontà di Riscatto che lega e accomuna tutti i protagonisti della storia e che ha la forza prorompente della speranza. A incarnare questa speranza è Linda, insospettabile protagonista della storia (e della Storia), che grazie ad amicizie, bisogni e letture ottiene finalmente la sua indipendenza, il suo Riscatto: non al singolare, grazie ad un matrimonio d’interesse, bensì al plurale, nella lotta comune.
Nel tentativo, difficile ma necessario, di costruire un mondo nel quale abbia ancora senso parlare di dignità e di giustizia.
“Suor” è stato pubblicato per la prima volta in Brasile nel 1934. La prima edizione italiana, a cura di Claudio Valentinetti, compare nella collana Oscar Mondadori nel 1985. Del 2007 è invece l’ultima ristampa della traduzione firmata da Daniela Ferioli per Einaudi.